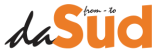È un nodo irrisolto se il cinema abbia estremizzato l’immagine della mafia tanto da diventare modello per i boss o se, viceversa, la mafia abbia fornito un immaginario di successo ad attori e registi. Quel che è certo però è che Mario Puzo e Francis Ford Coppola avevano capito tutto. Nella sublimazione artistica della figura del boss – del Padrino – hanno interpretato le mafie come mai nessun altro, hanno mostrato il valore che per un clan hanno l’ostentazione della ricchezza e del potere, l’esercizio della forza, della tirannia. E il senso della famiglia e della tradizione. Hanno colto la straordinaria capacità delle mafie di essere società, di imporre la propria presenza sulla scena, di godere di consenso sociale. Persino – come sottolineava Giovanni Falcone – di somigliarci.
Per questa ragione gli osceni funerali di Vittorio Casamonica oltre a essere un’evidente dimostrazione di forza, impunità e cattivo gusto, sono anche un nuovo tassello della strategia di costruzione di consenso sociale avviato anni fa dai Casamonica per rafforzarsi e lasciarsi alle spalle l’immagine dei parenti straccioni della mala romana: girando in Ferrari e indossando Rolex, sfoggiando impunità e agitando (sin dai tempi di Enrico Nicoletti) amicizie che contano, utilizzando i social network e fornendo beni e servizi a migliaia di persone che grazie ai Casamonica lavorano, mangiano, vivono. La loro crescita sociale, economica e criminale, quella delle altre organizzazioni, è avvenuta in stretta connessione con un processo di involuzione di una città incapace di cogliere l’aggressione delle mafie e che quindi non ha mai alzato un dito per difendersi.
Dentro questo contesto sociale è persino ovvio che un funerale possa trasformarsi in una Waterloo: la questura che candidamente spiega di non avere saputo nulla, di considerare Vittorio Casamonica un elemento “ai margini” della famiglia e che soprattutto non considera necessario partecipare alle esequie, il comune e il municipio che appaiono comprimari nel palcoscenico cittadino, il sacerdote don Giancarlo Manieri che rilascia interviste per negare l’evidenza e che per fortuna viene “sfiduciato” dall’Osservatore romano che considera quelle esequie “uno scandalo” per lo “lo spettacolo mediatico, l’ostentazione del potere, la strumentalizzazione chiassosa e volgare di un gesto di elementare pietà umana e cristiana come il funerale”. Fino al prefetto Franco Gabrielli (a cui il governo ha chiesto una relazione e che ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza per domani) costretto ad ammettere che “l’apparato di sicurezza non ha saputo cogliere i giusti segnali di quello che sarebbe successo”. Perché il tema vero non è che il sistema istituzionale non ha saputo (come emerge in queste ore), ma che non ha capito.
Il giorno dopo lo sfregio di don Bosco, lo scenario con cui Roma deve misurarsi è preoccupante. I funerali di Casamonica hanno rotto un argine, l’ennesimo. Non c’è più nessuna immagine della città da difendere. Eppure, a giudicare dalle reazioni del giorno dopo, resta fondato il rischio che neppure un corteo funebre sfacciato – con un carro trainato da sei cavalli, nove furgoni per le corone di fiori e 250 auto – dia la giusta misura dei fatti, che neppure quelle immagini così forti in cui la realtà supera la fantasia riescano a fare cogliere l’essenza delle cose. È come di fronte alla guerra vista al tg, che ci commuove per un istante ma non ci interroga davvero. Siamo talmente assuefatti al brutto, o lo consideriamo altro da noi, da non riuscire più a riconoscerlo come reale, e a reagire. Forse è anche per questo, come sottolineava su questo giornale Rosaria Capacchione, che a Roma uno “zingaro” come Vittorio Casamonica non può essere considerato mafioso, che Buzzi e Carminati “non sono mica la vera mafia”. Forse è per questo che resta diffuso il tentativo di sminuire o derubricare (“è corruzione, non è mafia”, “i Casamonica li conoscevano tutti”, “a Roma sono solo ladri”), forte la tentazione di usare i funerali per parlare d’altro, da Piergiorgio Welby ai migranti. Non è chiara, incredibilmente non ancora, la portata del potere delle mafie in città oppure, forse, è fin troppo evidente – da qui il silenzio reiterato del mondo dell’imprenditoria e delle professioni. Per questo, oggi più che mai, serve una risposta coraggiosa della città. Il Pd ha promosso già da ieri in maniera tempestiva un presidio in piazza don Bosco e ha lanciato una manifestazione per il 3 settembre. In una Roma offesa e smarrita serve un nuovo patto sociale e un’azione comune e rigorosa. Per farlo, bisogna aprire finalmente una discussione pubblica sulle mafie e il futuro di Roma. Senza sconti. Giace in Campidoglio da molti mesi una richiesta di cittadine e cittadini per un consiglio comunale aperto sulle mafie. Sarebbe ora di riprenderla in mano e darle seguito. La stessa cosa potrebbe fare il consiglio regionale. Le istituzioni potrebbero diventare il luogo – simbolico e concreto – per l’inizio di un ragionamento insieme ai cittadini. Un percorso lungo e complesso, capace di fare tesoro del lavoro delle associazioni che combattono un costante corpo a corpo con il disagio sociale nelle periferie e il welfare parallelo offerto dalle mafie, delle esperienze maturate al sud. Un confronto costante che può attraversare anche altre occasioni, come gli eventi organizzati da realtà come Libera o l’evento “Restart” che l’Associazione daSud organizza a fine settembre per il suo decennale e che avrà uno dei focus principali proprio su Roma.Nella Capitale sta accadendo qualcosa di enorme, che mette a rischio il funzionamento stesso della democrazia. Ciascuno – ognuno per la sua parte – deve sentirsi chiamato in causa. “Non c’è spazio per le zone d’ombra”, sentenzia l’Osservatore romano a proposito della chiesa. Neppure per la prudenza o le strumentalizzazioni. Deve valere per tutti.