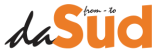La musica rientra sicuramente tra i più potenti linguaggi espressivi e di comunicazione in grado di creare un immaginario collettivo, condiviso e riconoscibile, un forte collante sociale capace di dar vita a vere e proprie comunità, seguendo la logica, se così possiamo definirla, del: dove-come-quando.
Della storia del Novecento ad oggi potremmo creare una vera e propria cartina geografica suddivisa per decadi ed elencare generi e movimenti musicali che hanno segnato, intrecciato ed accompagnato cambiamenti o fenomeni sociali.
Musica e mafie sono un binomio che sposa alla perfezione la teoria del: dove –come-quando e sottolinea come l’antimafia sociale sia in netto ritardo (tranne in sporadici episodi) anche su questo schema.
Lo scenario è quello del Sud Italia, dove le mafie controllano da decenni i territori e ne condizionando la quotidianità, creando modelli sociali sostanzialmente atipici.
In questo scenario la musica e gli artisti con un’indole alla tradizione e al folklore, tendono ad essere, ieri come oggi, assorbiti da questa “atipicità” che muta e diventa inevitabilmente un “prodotto tipico”.
LA CAMPANIA: L’INDUSTRIA DEI NEOMELODICI
L’esempio più noto e popolare è quello della Campania dove il fenomeno dei cantanti neo-melodici è estremamente popolare e rappresenta un’incredibile anomalia nel sistema nazionale. Le canzoni sono la parte minore di questa fenomeno, dove ovviamente l’uomo del clan risulta una figura onorabile e rispettabile, dove la latitanza è un gesto di coraggio, un vanto, ma non è l’unica tematica affrontata. Anzi. Le tematiche spesso sono delle più banali, dalla storia d’amore strappa lacrime, all’amore impossibile, quello che stupisce è il controllo totale di un mercato che non conosce crisi: case discografiche, tv locali di settore, riviste, festival e numeri(anche sul web) da star nazionali.
Questo “sistema”, in piedi da decenni, crea dei veri e propri idoli, seguendo uno standard preciso che impone i cantanti dai matrimoni alle feste patronali, rione per rione, provincia per provincia e va ben oltre i confini regionali, riscontrando enorme successo anche in Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia. Un’industria vera e propria che crea cultura e stereotipi ma sopratutto, crea un’ulteriore forma di controllo sui territori.
LA MUSICA DELLA ‘NDRAGHETA: IL CONSENSO
Diverso, solo per lo stile dei contenuti, il mercato discografico legato alla ‘ndrangheta, anche qui i numeri sono importanti e valicano i confini nazionali con vendite sopratutto nel Nord Europa, su internet si trovano collane intere di artisti acquistabili tramite importanti distributori nazionali, migliaia le visualizzazioni dei video su youtube seguiti da centinaia di commenti a sostegno degli artisti e non solo. La differenza la fanno i contenuti, qui si bada al sodo e si inneggia alle faide tra clan, alla vendetta (sopratutto da parte delle donne), all’uso delle armi, alla latitanza,all’odio nei confronti dei traditori. L’uso di un linguaggio tutt’altro che neutro tende ad innescare un meccanismo di riconoscimento del proprio contesto quotidiano, giocando una partita legata tutta sulla simbologia e sul concetto di appartenenza, dall’immagine del boss arrestato, alla donna che piange, dall’insegna di un paese trivellata dai bossoli all’immagine della Salerno/Reggio Calabria definita l’autostrada “della ‘ndrangheta”.
Simboli e regole, un lavoro tutto incentrato a sviluppare maggiore empatia tra chi vive il territorio e chi lo gestisce, una ricerca del consenso tramite la giustificazione di gesti estremi, legato a sentimenti come l’onore e al concetto di famiglia.
MUSICA E ANTIMAFIA: SCUSATE IL RITARDO
Mentre i brani che inneggiano ai clan e alle organizzazioni mafiose proliferano da tempo, gli artisti nazionali si attardano a trovare nella lotta alle mafie un argomento degno di nota. Con un’eccezione eccellente: è il 1971 quando i Giganti pubblicano il concept album di rock progressivo “Terra in bocca”, che racconta una storia di mafia legata alla gestione dell’acqua nella Sicilia che verrà censurata dalle radio. Bisogna aspettare l’omicidio di Peppino Impastato perché in Sicilia nascano i primi fermenti musicali con testi legati alle mafie. In Calabria negli anni Ottanta si fanno notare gli “Invece”, band di Bovalino (RC), che mescolano il punk e il reggae a testi contro le mafie. La stessa band perderà negli anni successivi il bassista Totò Speranza, vittima innocente della ‘ndrangheta: a lui è dedicato il pezzo “Ma comu si faci”. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta qualcosa inizia a muoversi. A firmare due capolavori della musica Italiana sono Francesco De Gregori con la profetica “Bambini venite parvulos” (in cui c’è il verso “legalizzare la mafia sarà la regola del 2000”) e Fabrizio De Andrè con “Don Raffaè”, brani che lasciano il segno e tracciano un solco importante nel panorama musicale nazionale. L’avvento della cultura hip hop e lo stretto legame che nei suoi primi anni ha con i movimenti e i centri sociali, crea un ulteriore passo in avanti nello sviluppo dei nuovi linguaggi artistici e più in generale facilita la crescita della musica di “protesta”.
Il grande pubblico deve attendere però il 1992 per conoscere il primo evento di richiamo nazionale dedicato alla lotta alle mafie. Accade dopo l’assassinio del giudice Giovanni Falcone quando allo stadio di Palermo va in scena “Giù la maschera”, con un parterre d’artisti importanti. Dopo le stragi siciliane i brani in memoria dei giudici e degli uomini della scorta non mancano, da “Cuore” di Jovanotti, passando per “Minchia signor tenente” che Giorgio Faletti portò al festival di Sanremo, fino a “L’appello” di Daniele Silvestri.
L’ultimo ventennio musicale ci ha regalato brani importanti e band o singoli artisti sempre più impegnati, questo dato è strettamente legato ad alcuni fattori. Il primo è certamente da attribuire alla crescita dell’antimafia sociale (associazioni o singoli cittadini) e quindi alla consapevolezza da parte degli artisti della necessità di “sfidarsi” sull’argomento e di dare un ulteriore spunto di riflessione agli ascoltatori con risultati anche importanti, come ad esempio “I cento passi” dei Modena City Rambles grazie anche alla complicità dell’omonimo film. Il secondo dato importante è frutto della maggiore visibilità che i media dedicano all’argomento “mafie” (se pur sempre in maniera occasionale e poco approfondita) e alla maggiore percezione che le persone hanno, rispetto al passato, del fenomeno mafioso.
Tutto questo va in contrasto con un ulteriore dato, la maggior parte degli artisti che decidono di misurarsi sul tema provengono da regioni meridionali, sposando alla perfezione il luogo comune che vuole le mafie un problema prettamente meridionale, inoltre sia le case discografiche che i media di settore sono poco propensi ad affrontare un argomento che scaturisce poco interesse da parte degli utenti, preferendo come sempre una visone più intima ed individuale che collettiva e sociale. Il bilancio è quindi ancora deficitario nei confronti della storia dell’antimafia di questo Paese ed è necessario essere consapevoli che “nell’arte” di raccontare l’Italia non ci si può esimere dal raccontare quello che è il fenomeno mafioso in questa nazione e la sua complessità, bisogna andare oltre gli stereotipi e comprendere che sia la sfera individuale che quella collettiva spesso sono condizionate dal modo di agire delle mafie sulla società, sostanzialmente si avverte la necessità che l’antimafia diventi pre-requisito anche per la musica. In questa direzione si sono mosse diverse realtà proponendo un modelli musicali interessanti. Il Museo della ‘ndrangheta nel 2011 decide di produrre l’album “Resistenza sonora” dei Kalafro. La band che affonda le sue radici nel reggae e nell’hip hop è da sempre attiva nella lotta alle mafie, trova così un “amplificatore” mediatico e un ottimo partner per rendere ancora più efficiente i propri contenuti.
L’associazione daSud fa della sperimentazione dei nuovi linguaggi contro le mafie una delle sue colonne portanti, e ha costruito negli anni legami importanti con diversi artisti, da Peppe Voltarelli agli stessi Kalafro passando dai Tetes de bois fino a Daniele Silvestri e Niccolò Fabi. La sperimentazione ha prodotto una stretta collaborazione con i Popucià band di musica elettronica dedita alla mescolanza di suoni e di generi. Diversi i progetti nati dal connubio tra daSud e Popucià, da singoli brani come “Crime”, colonna sonora della “Lunga marcia della memoria” del 2009, “Un giorno migliore”, brano che accompagnava la campagna di comunicazione “Le mafie ci uniscono” sui 150 anni dell’unità d’Italia, alla produzione di concept ep come “Dub Aut”, un tributo a Radio aut e Peppino Impastato, dove la band ha messo in musica le trasmissioni originali della radio siciliana. Quest’ultimo anno il Mei (Meeting etichette indipendenti), la label indipendente M.K. e la casa editrice Rubbettino, in collaborazione con molti partner tra cui l’associazione daSud, hanno promosso il concorso ed il libro/cd “Musica contro le mafie” un ulteriore passo in avanti, di un cammino ancora decisamente lungo, nella sensibilizzazione alla lotta contro le mafie.